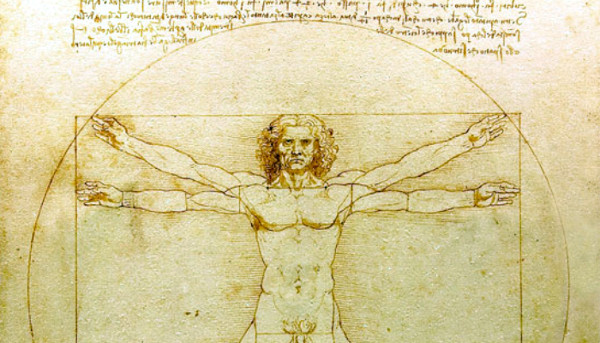In questi anni ho più volte cercato le ragioni di quello che considero il terreno di coltura della deriva reazionaria che ha portato il paese ad uno dei punti politici più bassi della sua storia.
Ho scritto più volte di quanto l’architettura reazionaria degli ultimi 30 anni abbia di fatto contribuito a negare, soprattutto nel nostro paese, ogni interferenza capace di cambiare le abitudini profondamente borghesi dell’architettura. Uso il termine borghese nella sua etimologia classica, che comprende in particolare la capacità di chi, intellettualmente, ha sempre combattuto la condizione di cui egli pare essere inesorabilmente schiavo; combattuto a parole poiché nei fatti la sua condizione abitativa e i suoi giudizi sono stati e restano profondamente conformisti. Buona parte dell’intellettualismo nostrano, ogni volta che ha dovuto confrontarsi con l’architettura nuova, con il governo del territorio e del paesaggio, non ha mai saputo abbandonare il riferimento alla propria identità storica e a quella che chiama memoria collettiva. Di fronte alle istanze nuove che, per quantità e tempistiche, non avevano riferimenti con la storia passata, la risposta è sempre stata soggetta al ricatto dell’antichità da subire.
La forza comunicativa e pedagogica dell’architettura non è mai stata completamente compresa, malgrado proprio il passato insegni quanto riscatto stia nei monumenti realizzati dal peggio dell’umanità. Monumenti che hanno perso la loro funzione salvifica e che oggi rappresentano lo sfondo retorico per ogni idea conservativa.
L’idea di contesto ha così pervaso ogni forma di progetto, col risultato di spegnere ogni volontà realmente riformatrice.
Questa idea, fortemente limitante e stringente, è cresciuta all’interno di un pensiero filosofico che rinunciava ai valori universali in favore di quelli contingenti e particolari. Un’idea, secondo me, discriminatoria, che incrina profondamente la visione unitaria del mondo, dividendolo in piccoli pianeti autarchici i cui i valori consolatori e appaganti non sanno attraversare i propri confini. Legittimare culturalmente quelle che la visione illuminista del mondo aveva definito credenze, e dar loro dignità e forza di verità relativa, ha riaperto i vasi di Pandora delle religioni meno esperte e dei vaneggiamenti razzisti, nazionalisti e antiscientisti attuali.
La condizione contemporanea è figlia di questo enorme errore politico e filosofico.
Il postmoderno architettonico non ci ha solo lasciato farsesco ciarpame edilizio, ma ha influenzato profondamente le persone abituandole ad una visione sconsolatamente autarchica dei propri valori esistenziali. Demonizzare l’universalismo, e la capacità degli uomini di vedersi con le stesse idealità e gli stessi valori, ha sicuramente soddisfatto la vanagloria di chi nell’internazionalismo vedeva affondare la propria vanità creativa, ma ha ferito gravemente i principi stessi che sono alla base della convivenza.
Questo è il mio pensiero più maturo, che con gioia ho rincontrato in buona parte in quello di Cinzia Sciuto, autrice del libro “Non c’è fede che tenga” (Feltrinelli), un vero manifesto illuminista che rimette in ordine un sistema di valori essenziale per la nostra democrazia.
È un libro di cui consiglio la lettura e che può ridare speranza ad una posizione critica autenticamente laica.
Di seguito lo stralcio di alcune parti dell’intervista lasciata dall’autrice al sito GliStatiGenerali.com.
“Alla difesa delle comunità religiose, lo Stato laico e democratico deve sempre e comunque anteporre la difesa del singolo individuo. E’ il singolo cittadino che deve essere tutelato non perché appartenente ad una determinata comunità ma in quanto persona e, se necessario, anche contro quella stessa comunità.”
“Mi sono cominciata a sentire fortemente a disagio quando ad un certo punto mi è stato detto, da più parti, che parlare di diritti delle donne è giusto solo se si rimane all’interno del nostro orizzonte culturale; al contrario, quando si ha a che fare con orizzonti culturali diversi dal nostro allora non è detto che il nostro sistema di valori e diritti sia sempre valido. Io ho una formazione filosofica di forte matrice illuministica, il mio riferimento filosofico principale è Immanuel Kant con il suo universalismo. Dunque questo approccio relativista a me è sempre parso da un lato logicamente contraddittorio, dall’altro moralmente aberrante.
Sulla questione della contestualizzazione storica e culturale delle battaglie per le libertà e i diritti individuali bisogna distinguere due livelli: una cosa è dire che bisogna conoscere i contesti locali e dunque essere consapevoli che, a seconda dei casi, le battaglie per i diritti dell’uomo possono essere condotte con diversi mezzi e che anche l’ordine di priorità può, delle volte, variare (per esempio, se negli anni ’60 e ’70 in Italia era prioritario il divorzio e l’aborto, non è detto che lo sia in tutti i contesti culturali allo stesso tempo); un’altra cosa, però, è mettere in discussione i principi ed i valori stessi in termini assoluti. Quest’ultima è una posizione, a mio avviso, da rigettare perché nasconde un razzismo inconsapevole: come a dire che in “altri” contesti, gli uomini e le donne non sono degni di godere dei “nostri” stessi diritti. Le battaglie per i diritti umani sono battaglie che coinvolgono l’umanità intera; anche noi, in Occidente, dobbiamo quotidianamente continuare a combattere. Nulla è dato per scontato”.
“Io credo sia importante in ambito laico criticare non solo le derive più estreme e concretamente violente ma anche e soprattutto i dogmi e le credenze stesse che ne sono alla base e che alimentano di fatto episodi come questi. Il problema non è soltanto evitare la violenza di per sé ma sviluppare un dibattito pubblico in cui si condanni senza se e senza ma omofobia, misogina e qualsiasi altra forma di discriminazione.”