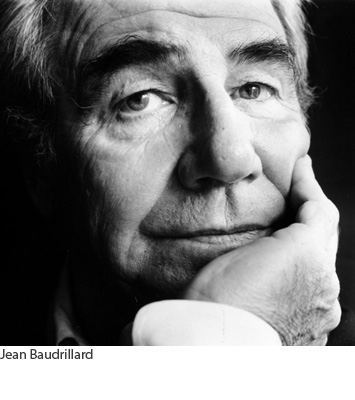Gli iconoclasti di Bisanzio fracassavano le immagini per cancellarne il significato (la figura visibile di Dio).
Anche noi, sotto l’apparenza del contrario e malgrado il nostro culto degli idoli, siamo sempre degli iconoclasti: distruggiamo le immagini schiacciandole sotto il peso del significato, le uccidiamo tramite il senso.”
(J. Baudrillard)
Jean Baudrillard è stato sicuramente un intellettuale scomodo e poco amato. Per tal motivo il suo pensiero ha subito una repentina sepoltura nel camposanto del manicomio postmoderno. Luogo nel quale, sono certo, sta malissimo e da dove vorrebbe andarsene con la stessa velocità con cui l’hanno sepolto molti suoi colleghi e contemporanei. Desiderio, questo, dal medesimo già espresso in vita: “Quello che non sopportava, mi disse una volta, erano domande come: cosa ne pensa del postmoderno? E lo infastidiva il fatto che venisse preso come ispiratore o filosofo della postmodernità .(1)
Se lo si rilegge alla luce di quanto i fatti, gli eventi, la nostra stessa realtà quotidiana abbiano perduto in “consistenza” non solo sociale ma addirittura individuale, ora che la società dell’immagine è giunta alla sua massima rivelazione, ma soprattutto se si riflette sull’esito dell’architettura di spicco degli ultimi dieci anni, non possiamo che contemplare alcune pertinenti profezie del suo pensiero e ammirarne la strabiliante attualità.
Mi riferisco, per provare quanto ho detto, all’ultimo periodo del suo lavoro intellettuale, da molti ritenuto oscuro per la sua latente trascendenza e per la serenità con cui, con tragica rassegnazione, egli ci descrive la scomparsa delle apparenze (rappresentazioni mentali della realtà fisica) usurpate dall’iperreale (rappresentazione realistica di una realtà solo mentale) e ci racconta con cinica ironia l’impossibilità pratica degli autori di quello che lui definisce “il delitto perfetto” di sbarazzarsi del cadavere del mondo. Rassegnazione scambiata per disimpegno o smarrimento filosofico che riducono il nostro autore a “un provocatore che getta ombre sulle cose ”.(2)
Ma non è così.
È sotto gli occhi di tutti quanto la rappresentazione dei fatti sia ormai a totale servizio del modo con cui vengono descritti; quanto la loro messa in scena sia più importante dei fatti stessi. È noto a tutti come qualsiasi programma giornalistico televisivo, schierato indifferentemente a destra o a sinistra, prima di proporre gli eventi ne stabilisca la loro rappresentazione, la loro mappatura, e ne determini il significato esclusivamente in funzione d’un senso gradito. Paradossalmente la mappa viene disegnata prima e indipendentemente dal territorio che la dovrebbe generare. È la realtà, quindi, a doversi adattare alla sua descrizione e non viceversa. Non c’è evento, non solo televisivo, nel quale gli attori e le loro situazioni, sempre più spesso rappresentate come autenticamente reali, vengano accomodate o, meglio, stravolte per poter soddisfare il gusto collettivo (in funzione di un premio o un sondaggio) o un altro scopo razionalmente calcolato.
Ora, quando il significato viene prima del significante, che fine fa la comunicazione? Ma, soprattutto, che fine fa la verità? (Stiamo parlando principalmente di verità, non di realtà).
La realtà filosofica, a questo punto, ci interessa poco se l’inautenticità, o meglio la falsificazione, riguarda anche il linguaggio con cui si dovrebbe negare l’evidenza del reale. Per questa ragione è essenziale che almeno il linguaggio sia autentico. Ed è estremamente importante che il linguaggio, come sostiene Baudrillard, sebbene per una via parecchio meno pragmatica di quella che sto raccontando, valga molto di più di ciò che dice .
“…ciò che davvero interessa Baudrillard non è il problema della conoscenza, né l’enfasi vitalistica che pervade i filosofi italiani del sublime. Per lui, infatti, l’illusione non significa sogno, inganno, miraggio, e nemmeno utopia, bensì l’ingresso in una dimensione non usuale, non quotidiana, non statica. Ed è a partire da questo momento che ha inizio una rivalutazione di ciò che chiamiamo l’arte, il teatro, il linguaggio: perché lì si è conservato qualcosa di quella violenza al reale che si attua nella cerimonia iniziatica e nel rito. ” (3)
Tirare in ballo la ritualità ci porta inevitabilmente in una regione di confine con la trascendenza ma, come sa bene la Chiesa Cattolica che sulla liturgia ha fondato la sua continuità, abolire il rito “…equivarrebbe a eliminare tutto il tema del linguaggio dei segni e dell’evocazione per accedere all’interno di un mondo che non trova altra risorsa per esprimersi se non quella del rito ”.(4) L’architettura non è un’istituzione, tantomeno religiosa anche se annovera parecchi credenti che a volte ce lo fanno pensare, ma riguardo al linguaggio dei segni può solo rivendicare la stessa necessità. Rito e linguaggio sono le sole risorse della sua autenticità.
La ragione? Il linguaggio, autentico lo è sempre perché, come il rito di cui è strumento, ha una sua struttura autonoma che non risponde a senso e significato se non all’interno della struttura stessa. Si può parlare per ore, usandone il linguaggio, di algebra o geometria senza dire nulla intorno alla realtà. Si può parlare per ore di musica o di grafica senza dire nulla intorno alla realtà. In ambedue i casi ci si può sbagliare, certamente, e fare degli errori, ma mai mentire. Si può essere “incoerenti” ma mai bugiardi. Escludendo il significato (l’idea che abbiamo della realtà del mondo) dalla nostra espressione (linguistica, artistica, scientifica) liberiamo il linguaggio dalla schiavitù del senso e dall’uso distorto che la nostra condizione di contemporanei ci costringe a farne. Se lasciamo al linguaggio la sua autonomia e non lo costringiamo nella condizione di servo del nostro destino, egli saprà raccontarci il mondo e la nostra storia con l’onestà e la sincerità che gli sono naturali.
Le implicazioni di tutto questo sono molto importanti, soprattutto in quel territorio dove l’espressione raggiunge i suoi livelli più sofisticati: l’arte.
Così Baudrillard: “ L’avventura dell’arte moderna è finita. L’arte contemporanea è contemporanea solo a se stessa. Non conosce più trascendenza verso il passato o il futuro, la sua unica realtà è quella della sua operazione in tempo reale, e del suo confondersi con tale realtà. (…)Non esiste più differenziale dell’arte. È rimasto soltanto il calcolo integrale della realtà. L’arte non è più altro, ormai, che un’idea prostituita nella sua realizzazione.”
“(…)È quanto fa appunto il ready-made, quando si accontenta di disinvestire un oggetto della sua funzione, senza alterarlo in alcun modo, per farne un oggetto da museo. Basta fare del reale stesso una funzione inutile per trasformarlo in oggetto d’arte, consegnandolo all’estetica divorante della banalità.” (5)
Aggiunge René Capovin (Baudrillard in Polvere): “Secondo Baudrillard, la maggior parte dell’arte contemporanea è mediocrità che si spaccia per arte passando dal primo al secondo livello, ‘ma è nulla e insignificante sia al primo che al secondo livello’. L’arte moderna, in quanto dominio dell’anti-utilitario, si è esaurita al momento della messa in scena della sua sparizione: Duchamp e Warhol non hanno inventato nuove forme di opposizione alla logica della merce, come consigliava la regola aurea del campo estetico, ma hanno raddoppiato la merce, ne hanno proposto un supplemento ecolalico (del tipo: tutto è merce, ‘appunto’). Tale messa in scena, però, se ripetuta, decade a simulazione della sparizione dell’arte: l’auto-sovversione diventa allora ‘complotto’, cioè complicità ‘occulta e alquanto turpe’ tra artista (che gioca al secondo, terzo, quarto, x-livello) e masse ‘stupefatte e incredule’. Che la scomparsa dell’arte venga ‘simulata’ non significa affatto che, ormai, la sua morte sia avvenuta: situata oltre la propria fine, l’arte è allo stesso tempo esaurita (in quanto sistema orientato da valori fissi, retto da un canone estetico) e in proliferazione incontrollata. Essendo collocata al di là della sua data di scadenza storica, ce n’è e ce ne sarà sempre di più, e in una misura tale da rendere impossibile un giudizio effettivamente ‘critico’ – dal momento che ‘tutto’ è arte, ‘si ha solo una spartizione in via amichevole, necessariamente conviviale,della nullità’.
Il corrispettivo nel campo intellettuale di questi nipotini di Warhol è costituito, per Baudrillard, dal postmoderno e dal pensiero debole.”
Ci risulta difficile contestare che il “poco”, anche dopo lunga riflessione, possa diventare altra cosa, malgrado i salti mortali degli acrobati del mondo dell’arte che da anni continuano a lucrare sulla banalità delle opere con utilissimi profitti (alla faccia della loro inutilità).
Ma le implicazioni riguardano maggiormente l’architettura, molto più pronta a cogliere, praticare e sperimentare le novità linguistiche, essendo per sua natura costretta ad un confronto sempre leale con la realtà (materiale e sociale). Non è un caso che proprio la disillusione postmoderna abbia rivelato la sua pochezza teorica nello squallore della propria produzione architettonica. La falsificazione diffusa, in cui inevitabilmente si casca quando il significato delle cose prevale sulla loro apparenza, ha mostrato la propria modestia nel momento in cui scrittura e linguaggio hanno rinnovato il loro ruolo e rivendicato la loro autonomia.
La falsificazione postmoderna – e conseguentemente neostoricista – ha infatti dimenticato che la storia ha scritto e scrive le sue frasi nella materia e non nella forma delle sue architetture. Rifare la forma sostituendone la materia sopprime la storia, non la salva e tanto meno la evoca, ma la uccide. Le cose rifatte (la conservazione del loro senso in assenza della scrittura originaria) smarriscono la profondità del tempo perché il rifacimento cancella la loro scrittura e, nella convinzione di sostituirle con un metalinguaggio adeguato, per il fatto che il linguaggio non può mai mentire, di fatto le si sostituisce con la loro desolante caricatura. Questi sono i limiti concettuali di teorie che riguardano l’uso della filologia e della tipologia in architettura e che, dal punto di vista della scrittura, risultano veri reati contro l’intelligenza creativa e si rivelano per quel che sono: argomenti accademici per amatori o, al massimo, prontuari per analfabeti della scrittura architettonica. Il fatto che Vittorio Sgarbi, possibile prossimo curatore del padiglione Italia della Biennale d’Arte di Venezia, da uno dei suoi abituali teatrini mediatici condanni pregiudizialmente qualsiasi nuova architettura priva di disciplina tipologica o ambientale, ci dà la misura dell’arretratezza e del limite della condizione autarchica della cultura nazionale.
Ma torniamo alla scrittura e alla sua libera autonomia. L’architettura di questi ultimi anni ci ha mostrato molti volti spesso confusi, costringendo il nostro giudizio a salti di quota che vanno dall’entusiasmo più alto alla delusione più profonda.
La ragione? Molta architettura subisce l’egemonia dell’arte figurativa e ne ripropone principi e limiti.
Altra architettura, pur generandosi da essa, ne ha scavalcato i valori superandone di gran lunga l’esito emozionale e artistico, tanto che molti critici e loro affiliati hanno spesso lamentato l’inadeguatezza delle nuove strutture museali accusate d’essere troppo rumorose rispetto alle opere esposte. Ma il problema, in verità, non riguarda la spettacolarità dell’architettura ma la pochezza dell’arte figurativa che la ricomparsa di una scrittura autentica ha messo a nudo. Occorre quindi distinguere le architetture che hanno autori capaci di una scrittura coraggiosa e libera da quelle che sorreggono la banalità dei loro testi su improbabili significati che spesso hanno a che fare con tutto tranne l’architettura.
Gli scrittori autentici, purtroppo, sono pochi e hanno coscienza del loro attuale primato sull’arte figurativa, concettuale e minimalista in particolare.
Certamente uno di questi è l’autore del museo Guggenheim di Bilbao.
Cos’altro è l’architettura di F. O. Gehry se non questo: libera, autentica, dirompente felicità della scrittura?
Possiamo contestare a questo autore la sua tendenza al manierismo, lo snobismo di una posizione privilegiata, se volete anche la mercificazione dei suoi segni. Ma nessuno può contestare sinceramente la dimensione titanica della sua scrittura, nella quale non c’è significato altro che per l’architettura e per il suo rituale. Nella sua profonda onestà, questa scrittura ci dà prova delle intuizioni dell’ultimo Baudrillard: liberata dal giogo del significato essa ci rivela la gioia dell’esistenza e ci ridà l’evidenza dell’architettura nella sua realtà più autentica. Nel Guggenheim di Bilbao la storia si rivela nuovamente una vicenda millenaria, grazie al suo linguaggio e alla sua scrittura.
Irrita qualcuno per la sua teatralità?
“Osceno è tutto ciò che è inutilmente visibile, senza necessità, senza desiderio e senza effetti. Ciò che usurpa lo spazio così raro delle apparenze.”
Note:
(1)
“Quello che non sopportava, mi disse una volta, erano domande come: cosa ne pensa del postmoderno? E lo infastidiva il fatto che venisse preso come ispiratore o filosofo della postmodernità. Baudrillard non si è mai identificato con l’oggetto delle sue osservazioni; così come è stato presente di fronte alla società iperreale basata sul principio della simulazione e della “scomparsa del reale”, lo è stato altrettanto di fronte alla razionalità degli oggetti della società del consumo cui corrispondeva l’irrazionalità dei bisogni degli anni ’60 e ’70. Qui il soggetto era come un “attrattore strano”, era la forza centripeta del consumo, nella società iperreale, invece, resta solo l’oggetto come attrattore strano, il soggetto scompare nell’oggetto. Attribuire certificati d’identità a un pensatore atipico come lo è stato lui, significa falsificarne l’immagine. Tra gli equivoci più grossi vi è quello dei “simulazionisti” newyorkesi, un gruppo di artisti emerso negli anni ’80, i quali si erano illusi di ispirarsi ai suoi scritti. Su questa prole spirituale non voluta Baudrillard è stato lapidario: “Non ho nulla di dire su loro. I miei testi potrebbero servire da giustificazione per qualsiasi cosa. Fare dei miei scritti una referenza è già in sé una simulazione ”. In tutti i suoi scritti vi è qualcosa di diabolico, qualcosa che sfugge sempre alla presa del pensiero, allo scambio nel concetto, ha fatto di tutto perché la sua scrittura si volatizzasse subito dopo esser apparsa.
Preferiva vivere a lato dei fenomeni, la vicinanza lo infastidiva, nella distanza si sentiva a suo agio. Era uno di quegli esseri per cui la storia o il senso che l’uomo attribuisce alle cose potevano pure non esistere, senza questo peso del valore che si attribuisce a ogni cosa il mondo per Baudrillard sarebbe stato ancora più magico. Amava le cose dissimili e gli universi paralleli come quello della Patafisica di cui ne è stato dopo la morte di Baj l’ultimo grande Satrapo. La Patafisica nelle sue mani diventava un’arma micidiale per il pensiero, e questo non gli è stato perdonato. Ma a Jean non importava. Amava Borges, i sui labirinti fatti di immagini che si perdono in altre immagini, e anche per il suo bestiario ideale. Era orgoglioso che il suo nome iniziasse con la B, la lettera che accomuna Baudelaire, Benjamin, Brecht, Barthes, autori da cui non si è mai staccato. Vedeva il mondo sempre come se fosse riflesso in uno specchio, che si divertiva a deformarlo, ad anamorfotizzarlo, e a volte a prenderlo alla lettera per scoprirne il ridicolo che cela.”
(http://www.ubishops.ca/BaudrillardStudies/obituaries_mfaletra-pf.html)
(2)
“In ultima analisi, Baudrillard è forse più utile come provocatore che sfida e mette in discussione la tradizione della filosofia classica e della teoria sociale che come qualcuno che fornisce dei concetti e dei metodi che possono essere applicati nell’analisi filosofica, sociale o culturale. Egli dichiara che l’oggetto della teoria sociale classica – la modernità – è stato superato da una nuova postmodernità e che perciò sono necessari strategie teoretiche, modi di scrittura e forme di teoria alternativi. Mentre il suo lavoro sulla simulazione e la rottura postmoderna, muovendo dalla metà degli anni Settanta fino ad arrivare agli anni Ottanta, fornisce una teoria postmoderna paradigmatica e un’analisi della postmodernità che è stata altamente influente, e che a discapito delle sue esagerazioni continua a essere impiegata per interpretare le tendenze sociali attuali, il suo lavoro successivo è probabilmente più di interesse letterario. In definitiva, Baudrillard va oltre la teoria sociale, in una nuova sfera del modo di scrittura che fornisce delle introspezioni occasionali all’interno dei fenomeni sociali contemporanei e critiche provocatorie della filosofia contemporanea e di quella classica e della teoria sociale.“
(http://www.filosofico.net/baudrillard7.htm)
(3)
Nella seconda fase, aperta dall’idea di strategia fatale, è centrale la parola «illusione», che va intesa sia in senso metafisico-cognitivo, ossia come il contrario della realtà e della verità, sia in senso estetico-psicologico, ossia come il contrario del disincanto e della delusione. Se si privilegia la prima accezione, il pensiero di Baudrillard acquista una coloritura scettico-nichilistica non lontana da alcune tendenze della filosofia italiana contemporanea – per esempio il «pensiero debole» di cui condivide il radicale rifiuto della metafisica e dell’etica, e quel filone della cultura filosofica caratterizzata dal catastrofismo vitalistico, che in Italia corre da Pirandello a Giorgio Colli e a Giorgio Agamben. Ma sono paralleli, in realtà, ingannevoli: perché ciò che davvero interessa Baudrillard non è il problema della conoscenza, né l’enfasi vitalistica che pervade i filosofi italiani del sublime. Per lui, infatti, l’illusione non significa sogno, inganno, miraggio, e nemmeno utopia, bensì l’ingresso in una dimensione non usuale, non quotidiana, non statica. Ed è a partire da questo momento che ha inizio una rivalutazione di ciò che chiamiamo l’arte, il teatro, il linguaggio: perché lì si è conservato qualcosa di quella violenza al reale che si attua nella cerimonia iniziatica e nel rito. È in quell’ambito che si conserva una padronanza delle apparizioni e delle sparizioni, e in particolare la padronanza sacrificale dell’eclissi del reale. Siamo quindi molto lontani dal gioco inteso come ricreazione, loisir o distrazione; l’idea che Baudrillard ha dell’arte come illusione è semmai prossima alla concezione antropologica della magia, dove la potenza dell’illusione riesce a irrompere nel reale e in qualche modo a prenderne il posto, senza però identificarsi con esso. Un passaggio fondamentale, questo, per capire una tra le idee più oscure della riflessione di Baudrillard, quella di strategia fatale. Non è un progetto o un piano di azione elaborato da un individuo, la strategia così come la pensa Baudrillard, bensì una concatenazione di elementi esterni alla volontà soggettiva: dunque è un sinonimo di regola e di rituale. Ma questa concatenazione non è né necessaria, né casuale, né teleologica, né fortuita, è un rito senza mito, un significante senza significato, tuttavia può diventare fatale, aggettivo cui Baudrillard consegna il senso di legato al male, funesto.
Tutte le cose sono chiamate ad incontrarsi – secondo il filosofo francese – solo il caso fa sì che questo appuntamento non si realizzi; al contrario, dunque, di quanto è proprio all’idea di “hasard objectif” dei Surrealisti, che in un mondo retto dalla casualità cercavano di attribuirle un significato e un valore reconditi indipendente dalle intenzioni e dalle volontà soggettive, scoprendo una trama occulta: una specie di astuzia della ragione (List der Vernunft) hegeliana. Sebbene Baudrillard dia invece per scontato che le cose si incontrino, non attribuisce a questo incontro alcun significato, perché non di una concatenazione provvidenziale si tratta, ma di un rituale, che tuttavia talvolta manca l’appuntamento e si trasforma in rituale mancato. La distanza estetica su cui si reggeva il rituale è però annullata, in occidente, dalla cancellazione della scena e dall’annientamento delle mediazioni, di qualsiasi tipo esse siano (artistiche, politiche, sessuali). In questa direzione l’analisi di Baudrillard si distanzia da quella di Guy Debord: il mondo attuale, infatti, non sarebbe caratterizzato dal trionfo dello spettacolo, ma dalla sua sparizione. La scena è stata sostituita dall’osceno, il posto dell’illusione è stato preso da qualcosa che pretende di fornire un effetto realistico maggiore dell’esperienza della realtà (ed è perciò iperreale), ogni evento è anticipato e annullato dalla pubblicità e dai sondaggi. Dunque l’azione diventa impossibile e ad essa succede la comunicazione, che riesce appunto a fare precipitare ogni cosa nell’insignificante, nell’inessenziale, nel derisorio. Nel mondo della comunicazione, nulla più accade: tutto è senza conseguenze, perché senza premesse, suscettibile di essere interpretato in tutti i modi, tutti ugualmente irrilevanti e privi di effetti.
(Testo di Mario Perniola pubblicato in “Il Manifesto”, 7 marzo 2007, col titolo “Potente e fatale la strategia di Jean Baudrillard”)
(4)
“L’azione liturgica consente di verificare che Dio non permane come un’illusione creata dalla mente dell’uomo, ma una realtà con cui riferirsi in maniera oggettiva nel susseguirsi dei tempi e degli spazi che assumono valore sacro”. A mettere in luce la centralità del rito nel discorso su Dio è stato monsignor Rino Fisichella, Presidente della Pontifica Accademia per la vita e Rettore della Pontificia Università Lateranense. Concludendo i lavori dell’evento internazionale “Dio oggi. Con Lui o senza di Lui cambia tutto”, promosso dal Comitato per il progetto culturale della Cei, monsignor Fisichella ha sottolineato che “il rito conferisce alla conoscenza di Dio uno spazio di comunicazione che ingloba l’intera realtà creata e l’uomo in essa”. “L’azione liturgica, il rito sono forme espressive e linguaggi con cui è necessario confrontarsi nel nostro parlare di Dio”, ha ribadito il Rettore dell’Università Lateranense per il quale sarebbe “illusorio pensare di emarginare questa dimensione”. Questo, ha aggiunto, “equivarrebbe a eliminare tutto il tema del linguaggio dei segni e dell’evocazione per accedere all’interno di un mondo che non trova altra risorsa per esprimersi se non quella del rito”. “L’analisi di questa componente – ha spiegato – mostrerebbe che si apre il passaggio per verificare quale relazionalità intercorre tra Dio e l’uomo senza cadere in forme di alienazione o psicosi”.
“Se le religioni hanno fatto del rito un elemento determinante – ha concluso – ciò implica che possiede un effetto essenziale e costitutivo nel discorso su Dio, per cui la cultura contemporanea non può né deve allontanarsi”.
(Mons. R. Fisichella: il rito fa sì che Dio non sia un’illusione)
(5)
“L’avventura dell’arte moderna è finita. L’arte contemporanea è contemporanea solo a se stessa. Non conosce più trascendenza verso il passato o il futuro, la sua unica realtà è quella della sua operazione in tempo reale, e del suo confondersi con tale realtà.
Nulla la distingue dall’operazione tecnica, pubblicitaria, mediatica, numerica. Niente più trascendenza, niente divergenza, niente altra scena: solo un gioco speculare con il mondo contemporaneo così come esso ha luogo. Per questo l’arte contemporanea è inesistente, perché tra essa e il mondo si ha solo un’equazione perfetta.
Fuori di questa complicità vergognosa, in cui creatori e consumatori comunicano senza dire una parola nella considerazione di oggetti strani, inesplicabili, che rimandano solo a se stessi e all’idea dell’arte, il vero complotto sta nella complicità che l’arte stringe con se stessa, nella sua collusione con il reale, grazie alla quale diviene complice di quella Realtà Integrale di cui è ormai soltanto il ritorno-immagine.
Non esiste più differenziale dell’arte. È rimasto soltanto il calcolo integrale della realtà. L’arte non è più altro, ormai, che un’idea prostituita nella sua realizzazione.”
(…)
“L’idea rivoluzionaria dell’arte contemporanea era che qualsiasi oggetto, qualsiasi dettaglio o frammento del mondo materiale poteva esercitare la stessa strana attrazione e porre gli stessi problemi insolubili che un tempo sembravano prerogativa di poche e rare forme aristocratiche dette “opere d’arte”.
Qui stava la vera democrazia: non nell’accesso di tutti al godimento estetico, ma nell’avvento transestetico di un mondo in cui ogni oggetto, senza distinzione, avrebbe il suo quarto d’ora di celebrità (e soprattutto gli oggetti senza distinzione). Tutti si equivalgono, tutto è geniale. Con il corollario della trasformazione dell’arte e dell’opera stessa in oggetto, senza illusione né trascendenza, acting out puramente concettuale, generatore di oggetti decostruiti che, a loro volta, ci decostruiscono.
Niente più volto, niente più sguardo, niente figura umana né corpo lì dentro – organi senza corpi, flussi, molecole, frattali. Il rapporto con l’”opera” appartiene alla sfera della contaminazione, del contagio: ci si connette, ci si assorbe, ci si immerge, esattamente come nei flussi e nelle reti. Concatenamento metonimico, reazione a catena.
Niente più oggetto reale in tutto questo: nel ready-made non c’è più l’oggetto ma l’idea dell’oggetto, e noi non godiamo più dell’arte ma dell’idea dell’arte. Siamo in piena ideologia.
E nel ready-made si riassume in fondo la doppia maledizione dell’arte moderna e contemporanea: quella di un’immersione nel reale e nella banalità, e quella di un assorbimento concettuale nell’idea dell’arte.
Sì, ma cosa diviene questa prospettiva del vuoto e dell’assenza in un universo contemporaneo già totalmente svuotato del suo senso e della sua realtà?
L’arte può ormai soltanto allinearsi sull’insignificanza e l’indifferenza generali. Non ha più alcun privilegio. Ha come unica destinazione finale questo universo fluido della comunicazione, delle reti e dell’interazione.
Emittente e ricevente si confondono nel medesimo anello: tutti emittenti, tutti riceventi. Ogni soggetto interagisce con se stesso, votato a esprimersi senza avere più il tempo di ascoltare l’altro.
Il Net e le reti moltiplicano evidentemente questa possibilità di emettere per proprio conto, a circuito chiuso, con ciascuno che mette in gioco la sua performance virtuale e contribuisce all’asfissia generale.
(…)
Interfaccia e performance: i due leitmotiv attuali.
Nella performance si confondono tutte le forme d’espressione – arti plastiche, foto, video, installazione, schermo interattivo. Questa diversificazione verticale e orizzontale, estetica e commerciale fa ormai parte dell’opera, il cui nucleo originale è irreperibile. (…)
In questo mixaggio universale, ogni registro perde la sua specificità – proprio come ogni individuo perde la sua sovranità nelle reti e nell’interazione – proprio come il reale e l’immagine, l’arte e la realtà perdono la loro energia rispettiva cessando di essere poli differenziali.
A partire dal XIX secolo l’arte vuole essere inutile. Se ne fa un titolo di gloria – cosa che non accadeva nell’arte classica dove, in un mondo che non è ancora né reale né oggettivo, il problema dell’utilità nemmeno si pone.
Per estensione di questo principio, basta portare un oggetto qualsiasi all’inutilità per farne un’opera. È quanto fa appunto il ready-made, quando si accontenta di disinvestire un oggetto della sua funzione, senza alterarlo in alcun modo, per farne un oggetto da museo. Basta fare del reale stesso una funzione inutile per trasformarlo in oggetto d’arte, consegnandolo all’estetica divorante della banalità.
Analogamente, le cose vecchie, antiquate, e quindi inutili, acquisiscono immediatamente un’aura estetica. Il loro scarto nel tempo è l’equivalente del gesto di Duchamp, divengono anch’esse dei ready-made, delle vestigia nostalgiche risuscitate nel nostro universo museale.
Si potrebbe estrapolare questa trasfigurazione estetica alla produzione materiale nel suo insieme. Una volta che essa abbia raggiunto la soglia al di là della quale non si scambia più in termini di ricchezza sociale, tale produzione diviene come un gigantesco oggetto surrealista, preso da un’ estetica divorante, e si inscrive dappertutto in una sorta di museo virtuale. Museificazione a tambur battente, come un ready-made, di tutto l’ambiente tecnico sotto forma di zona industriale dismessa.
La logica dell’inutilità non poteva che portare l’arte contemporanea a una predilezione per lo scarto – anch’ esso inutile per definizione. Attraverso lo scarto, la figurazione dello scarto, l’ossessione dello scarto, l’arte si accanisce a mettere in scena la propria inutilità. Essa manifesta il suo non-valore d’uso, il suo non-valore di scambio – e, nel contempo, si vende carissima. ”
(J. Baudrillard – Il patto di lucidità o l’Intelligenza del Male)